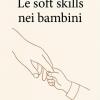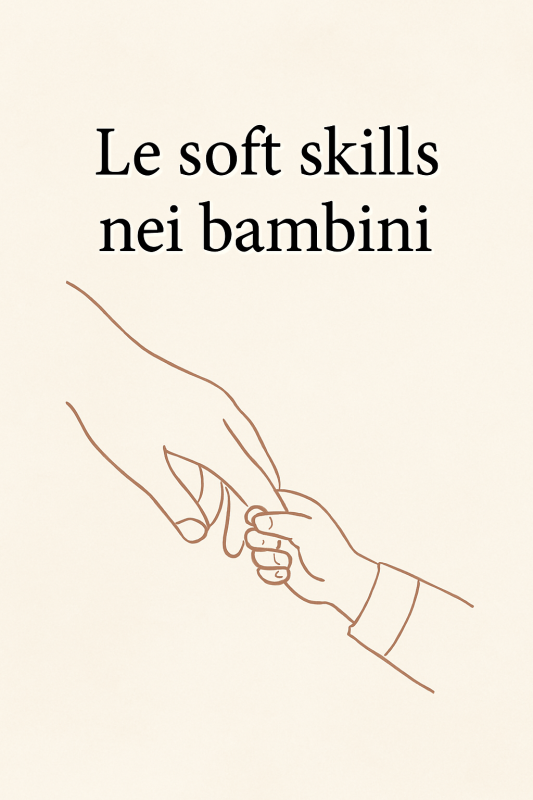
Siamo lieti di presentare sul sito di Far-Famiglia una serie di contributi che sintetizzano alcuni dei contenuti del volume Coaching e sviluppo delle Soft Skills di Massimo Tucciarelli, coach professionista con una lunga esperienza nell’ambito educativo e formativo.
La serie - che si articolerà in cinque puntate con cadenza mensile - mette in luce come l’educazione “ai buoni comportamenti”, da sempre al centro della proposta di Far-Famiglia, trovi un solido riscontro scientifico nelle più recenti ricerche sullo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills). Allenare i bambini sin da piccoli a comportamenti virtuosi, coerenti e consapevoli non è solo una scelta educativa valida, ma una strategia fondamentale per lo sviluppo equilibrato della persona, fin dai suoi primi anni.
INTRODUZIONE
Ho aderito con piacere all’invito di Far-Famiglia di pubblicare sul sito web di Far Famiglia - in cinque puntate, comprensive di questa Introduzione - un estratto del mio libro Coaching e sviluppo delle Soft Skills (Editrice La Scuola, Brescia, 2014).
I motivi per i quali ciò mi sembra utile sono connessi con la convinzione che la diffusione di una cultura pratica sulle soft skills sia sempre più importante nel mondo di oggi per consentire a coppie di genitori giovani di incidere sulla formazione del carattere dei figli quando questi sono ancora piccoli.
Fino a quando i figli hanno meno di dieci anni sono generalmente aperti ad accogliere i messaggi che ricevono dai genitori, con l’unica condizione che tali messaggi appaiano coerenti: sia nel senso che ciò che dice la mamma coincida con ciò che dice il papà, sia nel senso che ciò che entrambi dicono al figlio sia da loro messo in pratica. Quando tali condizioni si verificano i figli fanno generalmente ciò che i genitori suggeriscono loro. Se tali suggerimenti riguardano comportamenti ripetuti che sono in linea con l’acquisizione e il progresso in una determinata qualità umana, il figlio si sforza con libertà di comportarsi in tal modo, e facendolo, senza rendersene conto, cresce in quella qualità. Ciò costituisce un investimento di grande ricchezza per l’epoca in cui, da adolescente, sarà chiamato ad esercitare consapevolmente la sua libertà nel connettere i propri comportamenti con i propri valori.
Si sperimenta che, quando manca questa spinta nei primi anni di vita, se i figli giungono all’adolescenza senza un bagaglio di soft skills acquisite, è sempre più difficile per loro l’acquisirle, perché ciò passa attraverso delle scelte valoriali che sono, in quella fase della vita, frutto della libertà. Diversamente che in altre epoche della storia, gli stimoli che un adolescente oggi riceve rispetto ad un uso incoerente e contraddittorio della libertà sono moltissimi: basta pensare ai messaggi che giungono attraverso i social media per comprendere che, se non si è costruita prima una solida base di virtù, è difficile che l’adolescente riesca a farlo dopo.
Perché i genitori riescano ad allenare i figli nelle virtù fin da piccoli, occorrono, oltre a quello della coerenza, cui ho accennato prima, altri due presupposti:
1. Il primo è che colgano il collegamento fra certi comportamenti e una virtù, intesa come la radice interiore che consente di realizzare tali comportamenti con facilità ed energia.
2. Il secondo è che loro stessi acquisiscano la cultura relativa al miglioramento in certi comportamenti abituali mediante lo sforzo mirato: cosa che passa necessariamente attraverso un percorso di crescita personale.
Orbene, una esperienza diffusa ci dice che il livello medio di tali presupposti nella mente dei genitori di figli piccoli è in genere molto carente. L’importanza che attribuiscono a tali fattori cresce rapidamente quando si accorgono che i figli hanno qualche problema nell’ottenimento di risultati scolastici o lavorativi e nelle loro relazioni; ma, generalmente, a quel punto è troppo tardi per intervenire nel modo in cui sarebbe stato possibile alcuni anni prima.
Perciò ritengo sia un obiettivo strategico quello di portare i genitori giovani a un maggiore livello di consapevolezza rispetto alla pratica delle virtù, in primo luogo quelle proprie, e quindi quelle dei figli piccoli.
Nella mia professione di coach, che ho praticato da trent’anni in diversi ambiti (aziendale, universitario, liberi professionisti), negli ultimi anni mi sono concentrato sulle scuole materne e primarie (con dirigenti scolastici, docenti e genitori), proprio per la possibilità di aiutare i genitori in questo campo. Ho avuto diverse conferme che la strada è quella buona.
Lo strumento concettuale di cui mi sono servito è quello delle competenze: termine che ormai è divenuto di uso comune in ambito sia universitario che aziendale, vuoi per la descrizione delle virtù personali (alle quali corrispondono le cosiddette competenze trasversali) che per la descrizione delle virtù specifiche di ogni professione (alle quali corrispondono le cosiddette competenze professionali). Mi sono servito anche dell’espressione soft skills che traduce “competenze trasversali” (mentre hard skills traduce “competenze professionali), pur tenendo presente che si tratta di una “sineddoche”, cioè dell’indicazione di una parte per il tutto, perché skills indica l’aspetto interiore delle capacità, mentre la competenza è definita dai comportamenti.
Questa equiparazione mi è sembrata molto opportuna perché lo studio dei comportamenti, messo in primo piano dalla teoria delle competenze, va integrato con la consapevolezza dei cosiddetti “abiti” interiori, che consentono di realizzare comportamenti utili dopo una valutazione della singolarità di ogni situazione.
Quando tale integrazione viene realizzata correttamente, è possibile giovarsi della ricchezza dei moderni studi sulle competenze, che identificano e “fotografano” i comportamenti che è necessario praticare per ottenere certi risultati.
A completamento di questa introduzione, faccio presente che negli ultimi cinquant’anni si è verificata una vera rivoluzione nel campo della psicologia applicata al lavoro. Da quando, nel 1973, David McClelland pubblicò il suo celebre studio sui rapporti fra quoziente intellettuale e successo professionale, contenente una prima definizione del concetto di competenza1, si sono succedute innovazioni teoriche e nuove metodologie che hanno modificato profondamente l’approccio alla formazione. Si pensi agli studi dei più famosi discepoli di McClelland, come Richard Boyatzis2 nel campo delle competenze e Daniel Goleman3 nel campo dell’intelligenza emotiva. Si pensi anche al contemporaneo sviluppo di correnti della psicologia improntate allo sviluppo del potenziale e degli aspetti positivi della persona, come quelle che fanno capo ad Albert Bandura4 e al suo concetto di self-efficacy5, a Martin Seligman6 e al collegamento da lui evidenziato fra la pratica delle virtù e l’ottimismo7, a Mihaly Csikszentmihalyi8 e al suo concetto di flow9. Si pensi infine, dal punto di vista dell’applicazione pratica, ai nuovi approcci dell’analisi transazionale10, della programmazione neurolinguistica11 e del coaching.
Sono stato testimone delle applicazioni di queste nuove idee e metodologie, che ho potuto conoscere e approfondire quasi in tempo reale grazie alla lungimiranza della Fondazione Rui12, per cui ho lavorato fino a pochi anni fa. La Fondazione, che ha una forte dedicazione alla formazione dei propri dirigenti e una marcata proiezione internazionale, mi ha consentito di instaurare e coltivare rapporti con esperti che mi hanno guidato nell’apprendimento.
Ho raccolto nel libro intitolato Coaching e sviluppo delle soft skills – che segue di alcuni anni un altro dal titolo Il coaching universitario per competenze: principi, metodologia, esperienze (pubblicato da Franco Angeli nel 2009) – una sintesi della mia esperienza sullo sviluppo delle competenze trasversali. Si tratta di un tema che costituisce il crocevia di vari percorsi e interessi: di chi si appresta a entrare nel mondo del lavoro; di chi vi è già entrato e vuole diventare più efficace e avanzare nella carriera; di chi vuole migliorare le proprie relazioni sociali, amicali, affettive; di chi vuole svolgere meglio il proprio ruolo di educatore, come un genitore nei confronti dei propri figli o un insegnante nei confronti dei propri allievi.
Riporto nelle prossime quattro “puntate” di questo intervento sul sito di Far Famiglia gli aspetti che penso possano essere utili per i genitori di figli piccoli, integrati da due strumenti diagnostici:
- una mappa delle soft skills dei genitori, con una scheda di autovalutazione;
- una mappa delle soft skills dei bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni, con la corrispondente scheda di valutazione da parte dei genitori.
Rispetto a dubbi o esigenze che scaturiscano dalla lettura di questi testi, sono disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta. A tal fine comunico la mia e-mail: massimo.tucciarelli@gmail.com
Note
1) D.C. McClelland, Testing for Competence Rather than Intelligence, in «American Psychologist», 28 (1973), pp. 1 – 14.
2) Nato nel 1946, è professore di Organizational Behavior presso la Case Western Reserve University. Il suo primo libro sulle competenze è stato The Competent Manager: a Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, Hoboken 1982. Altre opere saranno citate in seguito.
3) Nato nel 1946, laureato ad Harvard in psicologia clinica e sviluppo della personalità, ha divulgato le scoperte realizzate negli ultimi decenni dagli studiosi di neurologia e psicologia delle emozioni. La sua opera principale è Emotional Intelligence, pubblicata nel 1995 (tr. it: Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996). Altre opere saranno citate in seguito.
4) Nato ad Alberta (Canada) nel 1925, ha insegnato alla Stanford University ed è stato Presidente della American Psychological Association. Vedi A. Bandura, Autoefficacia: teoria e applicazioni (1997), tr. it., Erickson, Trento 2000; Id., Self Efficacy: Torward a Unifying Theory of Behavioral Change, in «Psychological Review», 84 (1997), pp. 191-215.
5) Il senso di autoefficacia è la convinzione che la persona nutre sulle proprie capacità, sull’avere il controllo degli eventi della propria vita e sul potere, di conseguenza, accettare le sfide nel momento in cui esse si presentano e riprendersi da eventuali insuccessi.
6) Nato a New York nel 1942, insegna alla University of Pennsylvania ed è stato Presidente della American Psychological Association. Vedi M.E.P. Seligman, Imparare l’ottimismo (1990), tr. it., Giunti, Firenze 2005; Id., La costruzione della felicità: cos’è l’ottimismo, perché può migliorare la vita (2002), tr. it., Sperling Paperback, Milano 2005.
7) La sua psicologia prende il nome di “psicologia positiva” perché intende promuovere la felicità nelle persone normali, anziché limitarsi a curare le persone malate. Collega la felicità con la piena attuazione da parte di ciascuno delle proprie capacità personali, delle quali fa una classificazione raggruppandole attorno a sei “virtù” (saggezza, trascendenza, temperanza, coraggio, umanità, giustizia).
8) Ungherese, nato a Fiume nel 1934 ed emigrato negli Stati Uniti, ha insegnato alla University of Chicago e alla Claremont Graduate University. Vedi M. Csikszentmihalyi, La corrente della vita: la psicologia del benessere interiore (1990), tr. it., Frassinelli, Torino 1992.
9) Il flow è definito come uno stato di concentrazione e completo assorbimento mentale nell’attività che si sta svolgendo, tale da coinvolgere positivamente l’emotività della persona e favorire il massimo rendimento.
10) L'analisi transazionale parte dall’idea che nell’io si integrano tre dimensioni o stati: genitore, adulto, bambino. Essa studia gli scambi (transazioni) che si possono realizzare fra le persone, a seconda che la questione che le accomuna veda coinvolto in maniera dominante uno degli stati. Cfr. C. Moiso, M. Novellino, Stati dell'Io. Le basi teoriche dell'analisi transazionale integrata, Astrolabio Ubaldini, Roma 1982; I. Stewart – V. Joines, L'analisi transazionale. Guida alla psicologia dei rapporti umani, Garzanti, Milano 2000.
11) La Programmazione Neurolinguistica (PNL) è un approccio alla comunicazione e allo sviluppo personale iniziato da Richard Bandler e John Grinder in California negli anni ’70 del secolo scorso. Esso studia la connessione fra i processi neurologici ("neuro"), il linguaggio ("linguistica") e gli schemi comportamentali appresi con l'esperienza ("programmazione"), al fine di riorganizzare questi schemi in modo funzionale al raggiungimento di obiettivi. Cfr. R. Bandler – J. Grinder, La struttura della magia (1975), tr. it., Astrolabio Ubaldini, Roma 1981; R. Bandler – J. Grinder – R. Dilts – J. DeLozier – C. Bandler, Programmazione Neurolinguistica (1980), tr. it., Astrolabio Ubaldini, Roma 1982.
12) La Fondazione Rui (Residenze Universitarie Internazionali) gestisce collegi universitari nelle principali città italiane, con attenzione alla formazione globale